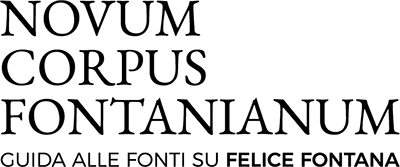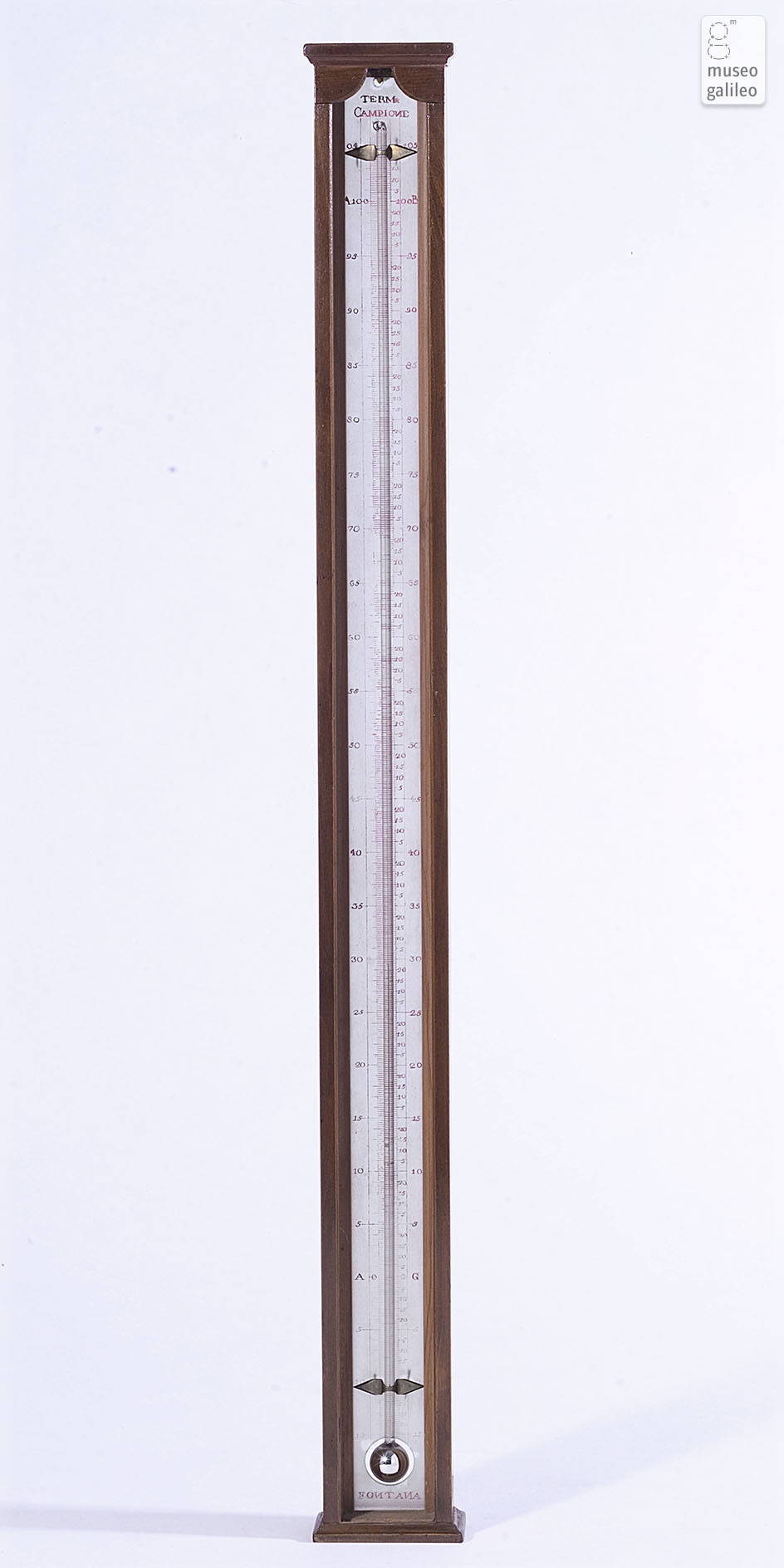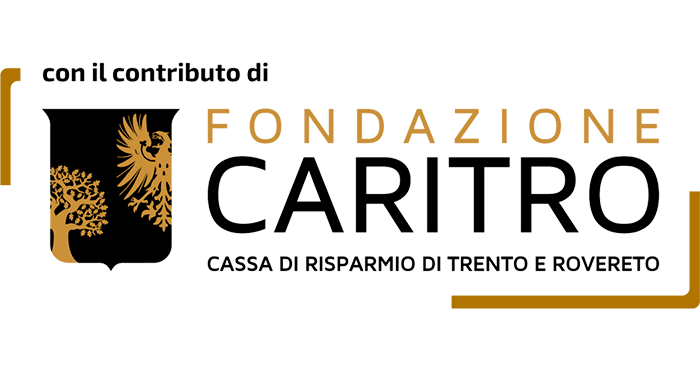FUOCO
Il fuoco è uno dei quattro elementi fondamentali secondo la filosofia, la fisica e la cosmologia classiche. Questi quattro elementi formavano la base teorica del pensiero sulla materia fino alla fine del diciottesimo secolo: costituiscono le sostanze nelle quali si possono scomporre tutte le cose e che a loro volta non possono essere scomposte in altre. Esse sono contenute in ogni cosa concreta in diversa quantità, ma non compaiono mai in forma pura, come Aristotele aveva dedotto da Empedocle.
Fra le sue ricerche compaiono quelle incentrate sul flogisto. È veramente difficile spiegare di cosa si trattasse, in quanto da quasi tutti coloro che ne parlavano fu definito in maniera molto varia. Il nome fu coniato da Stahl, in base agli studi sul principio di infiammabilità, espulso nella combustione. Non si trattava del fuoco stesso, ma del vero agente che lo provocava: quando non era combinato, esso non era niente di simile al fuoco, ma si volatilizzava in particelle invisibili, da cui veniva prodotto semplicemente calore. Per Stahl non si trattava di una sostanza materiale. In definitiva, la teoria del flogisto fu un ostacolo al progresso della comprensione: non costituì uno stimolo alla ricerca e la chimica progredì anche a dispetto di essa.
Bibliografia
Fontana, Felice, Articolo Di Lettera scritta dal Medesimo al Fratello Pubblico Professore di Matematica nell'Università di Pavia. Sopra la Luce, la Fiamma, il Calore, e il Flogisto, Verona, Memorie di Matematica e Fisica della Società Italiana, 1782
Knoefel P.K., Felice Fontana life and works, Trento, 1984
Parole chiave
Fuoco | Elemento | Calore | Luce | Flogisto